“Giubileo” è il nome di un anno particolare, apparentemente derivato dallo strumento utilizzato per indicarne l’inizio: lo yobel, il corno di pecora, il cui suono annuncia il Giorno dell’Espiazione (Yom Kippur). Questa festa si tiene ogni anno, ma assume un significato speciale quando coincide con l’inizio dell’anno del Giubileo. La prima idea si trova nella Bibbia: doveva essere indetto ogni 50 anni, perché era l’anno “extra”, da vivere ogni sette settimane di anni (cfr. Lev 25:8-13). Anche se difficile da realizzare, si proponeva come un’opportunità per ristabilire il corretto rapporto con Dio, tra le persone e con la creazione, e prevedeva il perdono dei debiti, la restituzione delle terre alienate e il riposo della terra.
Citando il profeta Isaia, il Vangelo secondo Luca descrive anche la missione di Gesù: “Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai poveri, a proclamare la liberazione ai prigionieri e la vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore” (Lc 4,18-19; cfr. Is 61,1-2). Queste parole di Gesù divennero anche azioni di liberazione e conversione nella vita quotidiana dei suoi incontri e delle sue relazioni.
Nel 1300, Bonifacio VIII indisse il primo Giubileo, noto anche come “Anno Santo”, perché è un momento in cui sperimentiamo come la santità di Dio ci trasforma. La cadenza è cambiata nel tempo: inizialmente ogni 100 anni, è stata ridotta a 50 anni nel 1343 da Clemente VI e a 25 anni nel 1470 da Paolo II. Ci sono anche giubilei “straordinari”: nel 1933, ad esempio, Pio XI volle commemorare l’anniversario della Redenzione e nel 2015 Papa Francesco ha indetto l’Anno della Misericordia. Il modo in cui viene celebrato l’Anno Giubilare è variato: in origine coincideva con una visita alle Basiliche romane di San Pietro e San Paolo e poi con un pellegrinaggio. In seguito sono stati aggiunti altri segni, come la Porta Santa. Partecipando all’Anno Santo, potrai beneficiare dell’indulgenza plenaria.
Un processo giubilare è vissuto in uno spirito di fede, un’adesione filiale a Dio, una vera e propria conversione del cuore, una preoccupazione di costruire un mondo più umano e fraterno intorno a noi, l’atto di mettersi in cammino per compiere un passaggio, dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce.
La Chiesa propone sette segni giubilari distinti e complementari.
- Il pellegrinaggio

Giubileo significa intraprendere un viaggio e superare alcuni confini. Quando ci spostiamo, non cambiamo solo luogo, ma cambiamo anche noi stessi. Ecco perché è importante prepararsi, pianificare il viaggio e conoscere la destinazione. In questo senso, il pellegrinaggio che caratterizza quest’anno inizia prima del viaggio stesso: il suo punto di partenza è la decisione di compierlo. L’etimologia della parola “pellegrinaggio” è molto eloquente e ha subito pochi cambiamenti di significato. La parola deriva dal latino per ager, che significa “attraverso i campi”, o per eger, che significa “attraversare una frontiera”: entrambe le radici richiamano l’aspetto distintivo dell’intraprendere un viaggio.
Nella Bibbia, Abramo viene descritto come una persona in viaggio: “Lascia il tuo paese, la tua stirpe e la casa di tuo padre” (Gen 12:1). Con queste parole inizia la sua avventura che si conclude nella Terra Promessa, dove viene descritto come un “arameo errante” (Dt 26:5). Allo stesso modo, il ministero di Gesù si identifica con un viaggio dalla Galilea alla Città Santa: “Quando furono compiuti i giorni in cui sarebbe stato esaltato, prese la ferma decisione di partire per Gerusalemme” (Lc 9:51). Egli stesso chiamò i suoi discepoli a seguire questo cammino e ancora oggi i cristiani sono coloro che lo seguono e seguono le sue orme.
In realtà, il viaggio si costruisce gradualmente: ci sono diversi itinerari tra cui scegliere, luoghi da scoprire; le situazioni, le catechesi, i riti e le liturgie, i compagni di viaggio ci permettono di arricchirci di nuovi contenuti e prospettive. Anche la contemplazione del creato ne fa parte e ci aiuta a capire come la cura di esso “sia un’espressione essenziale della fede in Dio e dell’obbedienza alla sua volontà” (Francesco, Lettera per il Giubileo 2025). Il pellegrinaggio è un’esperienza di conversione, di cambiamento della propria vita per orientarla verso la santità di Dio. Con esso, facciamo nostra anche l’esperienza di quella parte di umanità che, per vari motivi, è obbligata a mettersi in cammino alla ricerca di un mondo migliore per sé e per la propria famiglia.
- La Porta Santa

Da un punto di vista simbolico, la Porta Santa assume un significato speciale: è il segno più caratteristico, perché l’obiettivo è quello di poterla attraversare. La sua apertura da parte del Papa rappresenta l’inizio ufficiale dell’Anno Santo. In origine esisteva una sola porta, quella della Basilica di San Giovanni in Laterano, la cattedrale del vescovo di Roma. Per permettere ai numerosi pellegrini di compiere il gesto, anche le altre basiliche romane offrivano questa possibilità.
Varcando questa soglia, ai pellegrini viene ricordato il testo del capitolo 10 del Vangelo secondo Giovanni: “Io sono la porta; chi entra attraverso di me sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo”. Il gesto esprime la decisione di seguire e farsi guidare da Gesù, che è il Buon Pastore. Inoltre, la porta è anche un passaggio che conduce all’interno della chiesa. Per la comunità cristiana, non è solo uno spazio sacro, da avvicinare con rispetto, con un comportamento e un abbigliamento adeguato, ma un segno della comunione che lega ogni credente a Cristo: è il luogo dell’incontro e del dialogo, della riconciliazione e della pace che attende la visita di ogni pellegrino, lo spazio della Chiesa come comunità di fedeli.
A Roma, questa esperienza assume un significato particolare, in quanto rimanda alla memoria di San Pietro e San Paolo, gli Apostoli che hanno fondato e formato la comunità cristiana di Roma e che, con i loro insegnamenti e il loro esempio, sono un punto di riferimento per la Chiesa universale. Il loro sepolcro si trova nel luogo in cui furono martirizzati e, insieme alle catacombe, è un luogo di continua ispirazione.
- Riconciliazione

Il Giubileo è un segno di riconciliazione, perché apre un “tempo favorevole” (cfr. 2 Cor 6,2) per la nostra conversione. Andando verso di Lui e riconoscendo il Suo primato, Dio viene posto al centro della nostra stessa esistenza. L’invito della Bibbia a ripristinare la giustizia sociale e il rispetto per la terra nasce anche da un’esigenza teologica: se Dio è il creatore dell’universo, dobbiamo dargli la priorità su tutta la realtà e sugli interessi di parte. È Lui che rende santo questo anno santo donandogli la sua santità.
Come ci ha ricordato Papa Francesco nella Bolla di indizione dell’Anno Santo straordinario 2015: “La misericordia non è contraria alla giustizia, ma illustra il comportamento di Dio nei confronti dei peccatori, offrendo loro una nuova opportunità di pentirsi, convertirsi e credere. […]. Questa giustizia di Dio è la misericordia concessa a tutti come grazia derivante dalla morte e dalla resurrezione di Gesù Cristo. La Croce di Cristo è quindi il giudizio di Dio su ciascuno di noi e sul mondo, poiché ci dà la certezza dell’amore e della vita nuova”. (Vultus misericordioso, n. 21).
In termini pratici, ciò significa sperimentare il sacramento della riconciliazione, approfittando di questo tempo per riscoprireil valore della confessione e ricevere personalmente la parola di perdono di Dio. Alcune chiese giubilari offrono questa possibilità in modo continuativo. Puoi prepararti seguendo uno schema.
- Preghiera

Ci sono molti modi e molte ragioni per pregare, ma alla base di tutto c’è il desiderio di aprirsi alla presenza di Dio e alla sua offerta d’amore. La comunità cristiana si sente chiamata e sa che può rivolgersi al Padre solo perché ha ricevuto lo Spirito del Figlio.
Infatti, è stato Gesù ad affidare ai suoi discepoli la preghiera del Padre Nostro, commentata anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica(CCC 2759-2865). La tradizione cristiana offre altri testi, come l ‘Ave Maria , che ci aiutano a trovare le parole per rivolgerci a Dio: “È attraverso una trasmissione viva, la Tradizione, che lo Spirito Santo insegna a pregare ai figli di Dio nella Chiesa”(CCC 2661).
I momenti di preghiera durante il viaggio dimostrano che il pellegrino ha le vie di Dio “nel suo cuore” (Sal 83:6). Questo è il motivo dei momenti di pausa e di riposo nelle varie tappe, spesso ambientate intorno a negozi di articoli religiosi, santuari o altri luoghi particolarmente ricchi di spiritualità, dove i pellegrini possono vedere che – prima e accanto a loro – sono passati altri pellegrini e che le vie della santità hanno percorso queste stesse strade. Infatti, le strade che portano a Roma spesso coincidono con i percorsi di molti santi.
- Liturgia

La liturgia è la preghiera pubblica della Chiesa: secondo il Concilio Vaticano II, è il “punto culminante verso cui è diretta tutta la sua azione” e “allo stesso tempo la fonte da cui scaturisce tutta la sua energia”(Sacrosanctum Concilium, 10). Al centro di tutto c’è la celebrazione eucaristica, dove si ricevono il Corpo e il Sangue di Cristo: come un pellegrino, Egli stesso cammina accanto ai discepoli e rivela loro i segreti del Padre, in modo che possano dire: “Rimanete con noi, perché si fa buio e si avvicina la sera” (Lc 24, 29).
Un rito liturgico caratteristico dell’Anno Santo è l’apertura della Porta Santa: fino al secolo scorso, il Papa iniziava, più o meno simbolicamente, demolendo il muro che la sigillava. Poi i muratori rimuovevano completamente i mattoni. Dal 1950, il muro viene demolito in anticipo e, durante una solenne liturgia corale, il Papa spinge la porta dall’esterno e la attraversa come primo pellegrino. Questa espressione e altre che accompagnano l’Anno Santo sottolineano che il pellegrinaggio giubilare non è un atto intimo e individuale, ma un segno del cammino di tutto il popolo di Dio verso il Regno.
- Professione di fede

La professione di fede, nota anche come “simbolo”, è un segno di riconoscimento specifico del battezzato; esprime il contenuto centrale della fede e riassume le principali verità che i credenti accettano e testimoniano nel giorno del loro battesimo e che condividono con l’intera comunità cristiana per il resto della loro vita.
Esistono diverse professioni di fede che mostrano la ricchezza dell’esperienza dell’incontro con Gesù Cristo. Tradizionalmente, tuttavia, quelle che hanno ottenuto un particolare riconoscimento sono due: il credo battesimale della Chiesa di Roma e il credo niceno-costantinopolitano, redatto nel 325 dal Concilio di Nicea, nell’attuale Turchia, e poi perfezionato nel Concilio di Costantinopoli del 381.
“Perché se le tue labbra confesseranno che Gesù è il Signore e il tuo cuore crederà che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Perché la fede dal cuore porta la giustizia e la confessione dalle labbra porta la salvezza”. (Rm 10:9-10). Questo testo di San Paolo sottolinea che la proclamazione del mistero della fede richiede una profonda conversione non solo nelle proprie parole, ma anche e soprattutto nella propria visione di Dio, di se stessi e del mondo. “Recitare il Credo con fede significa entrare in comunione con Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, e anche entrare in comunione con tutta la Chiesa, che ci trasmette la fede e nella quale crediamo”(CCC 197).
- Indulgenza
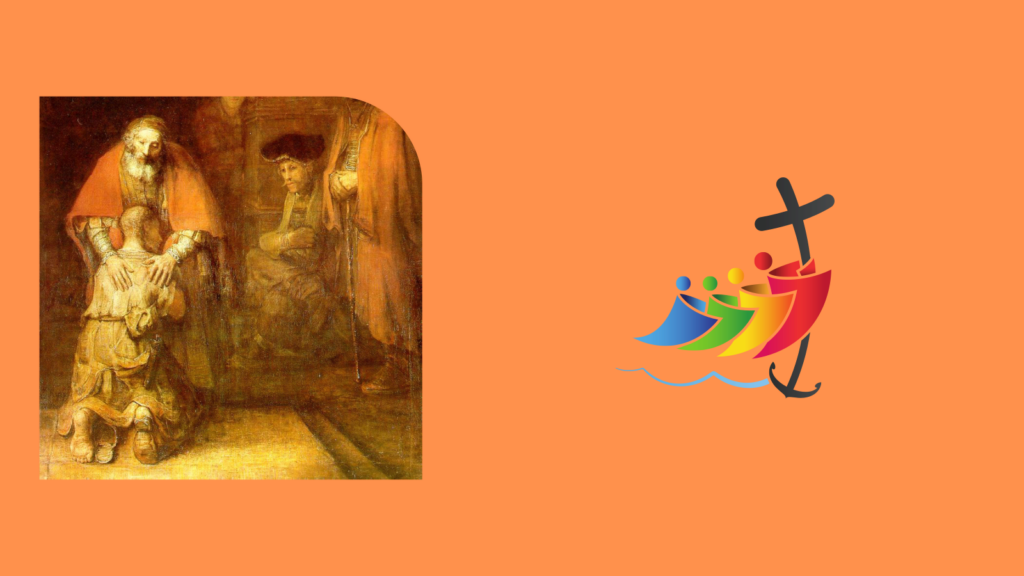
L’indulgenza è una manifestazione concreta della misericordia di Dio, che supera i limiti della giustizia umana e li trasforma. Questo tesoro di grazia si è fatto storia in Gesù e nei santi: guardando a questi esempi e vivendo in comunione con loro, la speranza del perdono e il cammino verso la santità si rafforzano e diventano certi. L’indulgenza ci permette di liberare il nostro cuore dal peso del peccato, in modo che la riparazione dovuta possa essere fatta liberamente.
In termini pratici, questa esperienza di misericordia comporta una serie di azioni spirituali indicate dal Papa. Coloro che, a causa di malattie o altri motivi, non possono essere pellegrini sono comunque invitati a prendere parte al movimento spirituale che accompagna questo Anno, offrendo le loro sofferenze e la loro vita quotidiana e partecipando alla celebrazione dell’Eucaristia.



